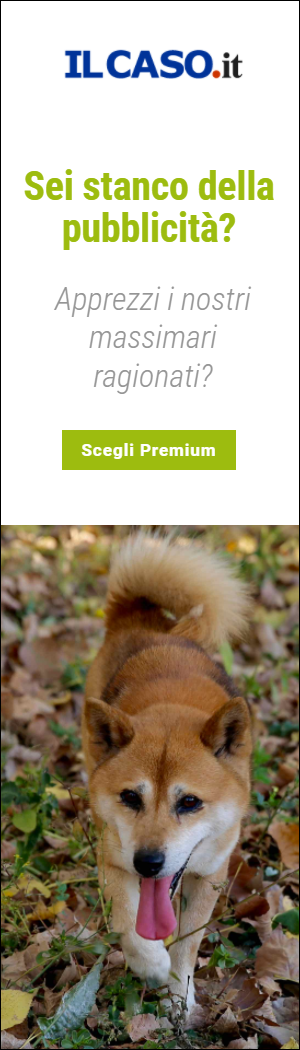È legittima la sanzione per dichiarazione infedele a carico del socio accomandante della sas, per maggior reddito derivante dall’accertamento nei confronti della società, divenuto definitivo. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 4712 del 22 febbraio 2024, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
La vicenda riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Di qui l’imputazione dei maggiori redditi ai soci per trasparenza. Sia la Ctp che la Ctr confermavano il recupero in termini di imposte, annullando l’avviso, in relazione alla sanzione per infedele dichiarazione.
Con il successivo ricorso per cassazione, l’ufficio denunciava violazione di legge, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano ritenuto che al socio accomandante non fosse imputabile alcun coefficiente di dolo o colpa per il maggior reddito accertato in capo alla società, e quindi, non gli dovessero essere addebitate le sanzioni previste, poiché? l'omesso controllo non sarebbe dipeso da negligenza o complicità, ma nella comprensibile fiducia nell'agire dei suoi familiari, anch'essi soci nei quali era concentrato il potere gestionale, al quale era estraneo, anche per formazione professionale.
La Cassazione ha accolto il ricorso.
Il socio di società di persone, che non dichiara, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultante dalla rettifica operata dall’ufficio a carico della società risponde delle sanzioni per l’infedele dichiarazione. Ciò vale anche per il socio accomandante di società in accomandita semplice. È irrilevante, infatti, l’estraneità di tali soci all’amministrazione della società, in quanto a essi è sempre consentito di verificare l’effettivo ammontare degli utili conseguiti. In questa ipotesi la sanzione non viene irrogata all’accomandante sulla base della mera volontarietà, in quanto la colpa consiste nell’omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sull’esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell’articolo 2320 cc (cfr Cassazione n. 19456/2009).
Il socio non solo è in grado di conoscere i rilievi e gli accertamenti fiscali effettuati nei confronti della società, ma il reddito di partecipazione è considerato suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dei metodi utilizzati dalla società per realizzarli, fermo restando il diritto del socio di agire nei confronti della società in sede civile ordinaria, per recuperare la quota di utili a lui spettante, nonché l’esclusione della sua responsabilità qualora sia dimostrata la sua buona fede (cfr Cassazione n. 11989/2015).
La posizione del socio, nell’ambito della compagine sociale, tanto nel caso in cui non rivesta la carica di amministratore, quanto qualora la rivesta, gli consente il controllo dell’attività della società e della sua contabilità e, quindi, di verificare l’effettivo ammontare del suo reddito e, pertanto, degli utili conseguiti in proporzione alla propria quota di partecipazione.
Nel caso in esame, la qualità di socio accomandante del contribuente non ha fatto venir meno l’imputabilità allo stesso, quantomeno per colpa, del maggior reddito accertato, di cui ha beneficiato per l’incremento di ricchezza della società. Il fatto che il contribuente avesse una formazione professionale estranea alla materia societaria non rileva, in quanto avrebbe potuto esercitare i suoi diritti amministrativi con l’ausilio di soggetti reputati competenti e accettando la veste giuridica di socio accomandante, ne ha inevitabilmente assunto i diritti gli obblighi e le responsabilità connesse alla posizione societaria ricoperta.
La suprema Corte ha, così, cassato la sentenza impugnata e deciso, nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
Osservazioni
Sul punto si ricorda che uno dei principi cardine del sistema sanzionatorio è quello della responsabilità personale, cioè della riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice della violazione. Tale assioma presuppone, nel caso di illecito, la coesistenza di due elementi: il primo, di natura oggettiva, si estrinseca nel comportamento (commissivo od omissivo) che viola la norma, mentre il secondo elemento è soggettivo e consiste in un atteggiamento psicologico caratterizzato dall'imputabilità (capacità d'intendere e di volere) e dalla colpevolezza.
Il legislatore esclude la responsabilità di chi ha commesso il fatto, per mancanza dell'elemento soggettivo indispensabile per fondarla, e delimita anche la nozione di colpa. Infatti, a proposito di colpevolezza - intesa come nesso psichico tra il soggetto e il fatto che costituisce il reato - la norma distingue tra colpa, che è qualificata a sua volta come grave o lieve, e dolo.
Il dolo presuppone l’intenzione specifica di commettere il fatto, con la consapevolezza di violare una disposizione di legge, in quanto è inteso come “l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero di ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”.
La ratio della norma trova il suo fondamento nel principio di responsabilità personale, che impone l’individuazione dell’autore materiale della violazione, cioè del soggetto che ha commesso l’atto illecito o che, avendone la responsabilità, non ha verificato la correttezza dell’adempimento macchiandosi di culpa in vigilando (cfr Cassazione n. 20099/2018).
In definitiva, la colpa del socio non amministratore consiste nell'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti contabili, nonché del diritto a ottenere il rendiconto dell'attività sociale. Invece il socio amministratore è in colpa nell'ipotesi di omesso o insufficiente esercizio dei poteri di gestione, direzione e controllo dell'attività sociale.