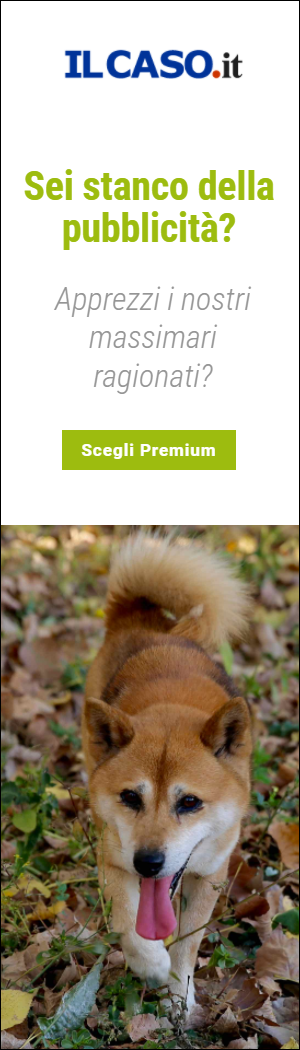Inammissibile la richiesta di omologare in modo forzoso per via giudiziaria una proposta di accordo di ristrutturazione per i soli debiti verso l’Erario, unico soggetto (dissenziente) coinvolto nell’intesa a fronte dell’integrale soddisfazione di tutti gli altri creditori. Anche alla luce delle modifiche normative, l’operatività del cram down fiscale richiede un preventivo accordo con altri creditori
Con la sentenza n. 5412 dello scorso 8 agosto la Corte d’appello di Roma torna a pronunciarsi sui requisiti di ammissibilità di una domanda di omologa forzosa di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
A fronte della mancata adesione dell’Agenzia delle entrate, una società chiedeva al Tribunale l’omologa forzosa ex articoli 57 e 63 comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii), di una proposta di accordo, evidenziando di aver offerto all’Erario il pagamento del 21,56% dell’esposizione debitoria con l’Ente (che rappresentava a sua volta l’86,79% del totale delle passività) a fronte del 3,85% di soddisfazione ottenibile da quest’ultimo in ipotesi di liquidazione giudiziale.
Il ricorso veniva accolto dal Tribunale, il quale, respinte le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria, riteneva sussistenti, nel caso in esame, i requisiti legislativi del proprio intervento sostitutivo.
In particolare, oltre alla decisività dell’Erario per il raggiungimento del 60% dei creditori aderenti e la convenienza della proposta di ristrutturazione rispetto alla soluzione liquidatoria, il Collegio di primo grado riteneva possibile applicare il cram down anche in presenza di un unico creditore, deducendo ciò a contrario dalla novella normativa prevista dal Dl n. 69/2023, convertito con legge n. 103/2023 (non applicabile ratione temporis al caso di specie), che impone per il cram down la compresenza di più creditori.
Avverso il citato provvedimento, l’Agenzia presentava reclamo deducendo, preliminarmente alle contestazioni relative alle ritenute ragioni di merito ostative all’omologazione, la violazione del combinato disposto degli articoli 57 e 63, comma 2-bis, del Codice della crisi d’impresa, ovvero l’assenza di un accordo da omologare e l’unicità del creditore sottoposto al cram down fiscale.
In altri termini l’Agenzia delle entrate contestava che, in assenza di un accordo da omologare, la richiesta della società si traducesse di fatto nell’indebita richiesta di omologa non di un accordo ma di una proposta di transazione non accettata dall’Amministrazione.
La decisione dei giudici romani
La Corte d’appello, con la sentenza in esame, aderisce alla tesi erariale e accoglie il reclamo dichiarando l’inammissibilità dell’istanza di omologa forzosa presentata dalla società.
Preso atto che la proposta di accordo prevedeva esclusivamente la ristrutturazione dei debiti della società verso l‘Agenzia delle entrate, unico soggetto coinvolto nel prospettato accordo essendo previsto espressamente il soddisfacimento integrale di tutti gli altri creditori societari rimasti estranei all’intesa, il Collegio ribadisce, anche in questa sede, le conclusioni già espresse dalla stessa Corte in un analogo precedente (decreto n. 2304/2024). In quel caso la Corte aveva, altresì, escluso che potessero intendersi come accordi “le dichiarazioni unilaterali di rinuncia ai crediti” rese da alcuni creditori. Le manifestazioni di volontà abdicativa dei relativi crediti non possono ritenersi, esse stesse, parti dell’accordo da omologare, dovendosi trattare piuttosto alla stregua di pattuizioni accessorie all’auspicato raggiungimento di un accordo con l’Erario.
In quel caso i giudici di secondo grado avevano ritenuto che la legge fallimentare presupponesse la necessità della preesistenza di un accordo di ristrutturazione, rispetto al quale si inserisse, in maniera determinante, la percentuale a capo del creditore pubblico forzosamente aderente, idonea a consentire il raggiungimento della percentuale minima di legge.
Questa conclusione veniva fatta discendere dal tenore letterale delle disposizioni che disciplinano gli accordi di ristrutturazione dei debiti, prevendendo, tra l’altro, la necessità del loro deposito e iscrizione nel registro delle imprese da parte del soggetto che ne richieda l’omologazione.
In altri termini era ritenuta necessaria la preesistenza degli “accordi di ristrutturazione”, rispetto al momento, evidentemente “successivo”, in cui il giudice è chiamato a effettuare la valutazione di maggiore convenienza della proposta di transazione fiscale (o previdenziale) rispetto all’alternativa liquidatoria, ai fini dell’adesione forzata dei relativi creditori agli accordi suddetti.
Il modello legale dell’articolo 182-bis, comma 4, della legge fallimentare (e sempre che risulti più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria) presuppone, sotto il profilo logico, che accordi di ristrutturazione siano stati raggiunti con altri soggetti, l’ammontare dei cui crediti non raggiunga il 60%, di modo che si renda necessaria l’estensione forzata al creditore pubblico (in presenza dei presupposti di legge), per ovviare al mancato raggiungimento della maggioranza richiesta.
Un’interpretazione ritenuta, del resto, coerente con le stesse ragioni che hanno portato il legislatore a introdurre il meccanismo del cram down finalizzato a superare “ingiustificate” resistenze alle soluzioni concordate della crisi di impresa (resistenze che si erano registrate nella prassi in riferimento alla relazione di accompagnamento al Dlgs n. 14/2019) nel prevalente “interesse concorsuale” che, come chiarito anche dalle sezioni unite della Cassazione (pronuncia n. 8504/2021), deve ritenersi sotteso (anche) alla procedura in oggetto.
Se si ritenesse ammissibile un accordo di ristrutturazione fondato sulla ristrutturazione dell’unico debito facente capo all’Amministrazione finanziaria, a fronte dell’integrale soddisfazione di tutti gli altri creditori ad essa estranei, non sarebbe configurabile alcun interesse concorsuale in funzione del quale sacrificare la volontà del Fisco a quella del debitore.
Così ragionando, l’istituto del cram down, da strumento funzionale a superare la mancata adesione dell’Amministrazione finanziaria (e/o degli enti previdenziali) a un accordo concluso con altri creditori concorsuali, si trasformerebbe nell’imposizione a tali soggetti di una soluzione unilaterale predisposta dal debitore, alla quale nessun altro creditore ha accettato di aderire.
Oltre alle argomentazioni già espresse nel precedente giurisprudenziale (appena richiamate), la Corte individua nel caso in esame i seguenti ulteriori elementi a supporto:
- il tenore letterale degli articoli 57 e 63 comma 2-bis, CCII, ovvero delle disposizioni che regolano il fatto di causa, porta a ritenere che la conclusione di un preventivo accordo debitore/creditore, a maggior ragione in caso di mancanza di adesione del creditore erariale e per l’operatività del cram down, è elemento costitutivo necessario di tale istituto
- le logiche proprie della volontà negoziale che regolano la fase della conclusione dell’accordo tra debitore e creditori si pongono come antecedente necessario all’omologa
- la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34/2020, nell’interpretare l’articolo 182-bis (interpretazione a detta della Corte “pacificamente estendibile anche agli artt. 57 e 63 ccii”) considera dati acquisiti necessari la conclusione di un preventivo accordo tra debitore e creditori e la presenza di creditori ulteriori rispetto all’Erario.
Riguardo l’interpretazione data sul punto dal Tribunale (il quale, come detto, attribuisce alla successiva modifica normativa di cui alla legge n. 103/2023, ovvero all’espressa previsione nella novella di una compresenza di più creditori aderenti all’accordo per l’operatività del cram down, l’elemento di novità rispetto all’operatività dell’istituto ante riforma anche con un creditore unico), la Corte d’appello ritiene al contrario che la previsione contenuta nella novella rappresenti piuttosto una più dettagliata codificazione della necessità, ai fini dell’operatività del cram down fiscale, di un preventivo accordo con altri creditori privati, già insita nel sistema degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57 e 63 Ccii ante modifica.
Così come già chiarito nel citato precedente, la Corte conferma che le novità introdotte con il Dl n. 69/2023, convertito con legge n. 103/2023 (articolo 1-bis) hanno fissato nuove e più stringenti condizioni per invocare il cram down negli accordi di ristrutturazione dei debiti (limiti minimi di soddisfacimento dei crediti fiscali e previdenziali e minime percentuali di rapporto tra i suddetti creditori e quelli originariamente aderenti all’accordo), ma non hanno inciso, tuttavia, sulla questione in esame ovvero sulla necessaria preesistenza di creditori aderenti ai fini dell’omologa forzosa, anche alla luce del regime normativo previgente.