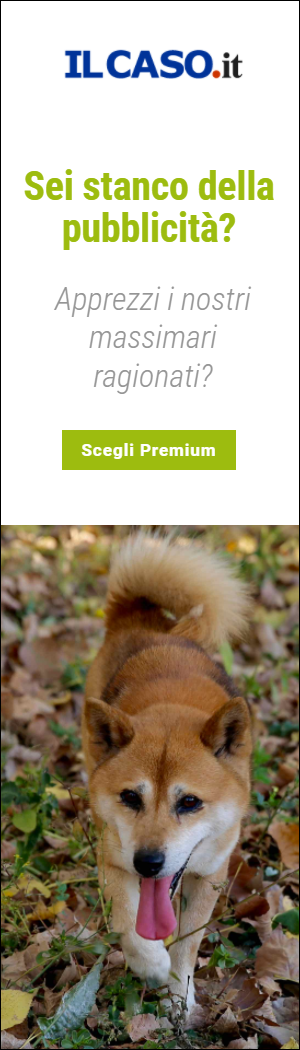Fatture soggettivamente inesistenti: prova contraria al contribuente
Pubblicato il 20/08/20 00:00 [Doc.7997]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate
11 Agosto 2020
L'assenza di dolo a carico dell'amministratore della società, decretata nel processo penale, è un motivo troppo debole per giustificare il fatto di aver agito in totale buona fede
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 13844 del 6 luglio 2020, ha chiarito rilevanti aspetti in tema di deducibilità e detraibilità dei costi collegati a operazioni soggettivamente inesistenti.
Nel caso concreto, la società contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento Ires, Irap, Iva, che recuperavano a tassazione costi indeducibili e indetraibili, ritenuti tali sulla base della fittizia interposizione nella compravendita di prodotti di telefonia mobile, attuata mediante la ricezione e l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
La Ctp di Torino rigettava i ricorsi, mentre la Ctr del Piemonte accoglieva l'appello della contribuente, ritenendo condivisibile il riferimento all'applicabilità dell'articolo 8, del Dl. n. 16/2012, che, in materia di fatture soggettivamente inesistenti, ai fini delle imposte dirette, prevede la deducibilità.
La Ctr richiamava poi, ai fini Iva, l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la detraibilità in caso di "mancanza di fraudolenza del contribuente", laddove, nel caso in esame, era stato anche emesso decreto d'archiviazione nei confronti dell'amministratore della società per l'assenza del dolo, quale elemento soggettivo del delitto d'evasione fiscale.
La Commissione tributaria regionale affermava, inoltre, che era comunque onere dell'ufficio dimostrare la falsità dell'operazione e che, nella specie, gli elementi addotti a sostegno delle pretese fiscali erano quegli stessi elementi forniti nel corso dell'indagine penale, laddove la società, a dimostrazione del proprio comportamento esente da dolo o frode, aveva sostenuto che l'interposizione le era stata imposta dal proprio partner commerciale.
L'Agenzia delle entrate proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo, fra le altre, l'errata interpretazione e applicazione dell'articolo 8 del Dl 16/2012 e la violazione dell'articolo 109 del Dpr n. 917/1986.
L'Agenzia rilevava infatti che, sebbene i costi rappresentati da fatture soggettivamente inesistenti non siano, per ciò stesso, riconducibili a quelli direttamente utilizzati per il compimento di delitti, in ogni caso la loro deducibilità resta subordinata all'esistenza dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, laddove, invece, la sentenza impugnata non si era pronunciata sull'inerenza degli acquisti dei beni di telefonia mobile da parte della contribuente, che, in quanto società immobiliare, non aveva certo tale attività nel proprio oggetto sociale.
L'Amministrazione deduceva, poi, il vizio di motivazione della sentenza, che aveva ravvisato la correttezza formale dell'operazione e la buona fede della contribuente, senza considerare tutti gli elementi allegati dall'Agenzia a dimostrazione del fatto che la stessa società aveva agito come una "cartiera" (assenza di qualsiasi struttura aziendale, rivendita al medesimo prezzo d'acquisto, eccetera), e comunque l'insufficiente motivazione della pronuncia, che si reggeva esclusivamente sull'archiviazione penale, omettendo di indicare perché erano stati ritenuti irrilevanti gli argomenti di prova di segno opposto offerti dall'ufficio, e non considerando che, nel menzionato decreto di archiviazione, pur escludendosi il dolo di evasione in capo all'amministratore della società, si affermava che era indiscutibile che la stessa società non fosse la reale destinataria della merce. Ciò, considerato che, peraltro, al fine di negare il diritto alla detrazione Iva, è sufficiente anche un comportamento meramente colposo dell'impresa nel non rilevare l'incongruenza tra la realtà effettiva e quanto esposto nelle fatture.
Secondo la suprema Corte le censure erano fondate.
Evidenziano infatti i giudici di legittimità che, ai fini della deducibilità dei costi apparentemente sostenuti per l'acquisto della merce, ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993 (nella formulazione introdotta con l'articolo 8, comma 1, del Dl. n. 16/2012), "sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una "frode carosello"), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo" (cfr Cassazione nn. 26461/2014; 17788/2018 e 13803/2014).
Nella fattispecie in esame, pertanto, la Ctr, discostandosi da tali princìpi, aveva erroneamente omesso di verificare la certezza e l'inerenza dei costi rappresentati dalle fatture contestate.
Quanto alle altre censure avanzate dall'amministrazione la Corte di cassazione rilevava poi che la falsità, anche soggettiva, della fattura è potenzialmente idonea a escludere la riconoscibilità del diritto di detrazione.
L'Iva, infatti, sottolineano i giudici, non è in questi casi, in linea di principio, detraibile, perché versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta; e in un simile contesto, ai fini della ripartizione dell'onere della prova, occorre dunque considerare che, se è vero che incombe sull'amministrazione finanziaria provare che difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione, una volta raggiunta questa prova, spetta poi però al contribuente fornire la prova contraria, ossia di avere operato in buona fede.
La dimostrazione che deve essere fornita dall'amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, rileva la Corte, s'incentra quindi sostanzialmente su due circostanze:
a) che il soggetto formale dell'operazione non è quello reale
b) che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva; e, in tal caso, non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione, ma è sufficiente che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole.
Vero è, afferma la Cassazione, che la circostanza che l'operazione si inserisca in una fattispecie fraudolenta di evasione dell'Iva non comporta automaticamente la perdita, per il cessionario, del diritto di detrazione, essendo configurabile un'esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato con il diniego del diritto di detrazione se "non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l'operazione interessata si collocava nell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente parte della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'IVA" (cfr Corte di giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C-439/04 e C-440/04; 21 giugno 2012, Mahagében e David, C-80/11 e C-142/11 e 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14).
Ma, come detto, tale conseguenza (l'indetraibilità) si verifica comunque se l'amministrazione prova, anche solo in base a presunzioni, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapeva, o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, con l'emissione della relativa fattura aveva evaso l'imposta o partecipato a una frode (cfr Corte di giustizia 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11 e Ppuh, C-277/14, paragrafo 50), visto che, in via meramente esemplificativa possono costituire indici sintomatici di tale stato soggettivo:
l'acquisto dei beni o dei servizi a un prezzo inferiore a quello di mercato
la limitatezza dell'eventuale ricarico
la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato
la tempistica e la modalità dei pagamenti (se, per esempio, incrociati o operati su conti esteri, a fronte di fornitori nazionali o effettuati in contanti)
la qualità dell'intermediario con il quale le operazioni commerciali sono state intrattenute.
Raggiunta tale prova, pertanto, è onere del contribuente dimostrare la propria buona fede, dimostrando di avere operato con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. Prova che può, ad esempio, riguardare l'attività conoscitiva preventiva eventualmente posta in essere, dalla quale fosse emerso un esito tranquillizzante circa l'effettività e l'operatività del soggetto interposto.
È comunque a tal fine irrilevante la prova sia della regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, sia della effettiva consegna della merce, sia dell'assenza di un vantaggio derivante dalla rivendita delle merci o dei servizi. Ciò in quanto le prime due circostanze sono insite nella nozione stessa di operazione soggettivamente inesistente (oltre che relative a dati e a documenti facilmente falsificabili), e l'ultima riguarda un dato di fatto esterno alla fattispecie tipica e inidoneo a dimostrare l'estraneità alla frode (cfr Cassazione nn. 13803/2014, 3474/2018 e 27566/2018).
Applicando i suddetti principi al caso in esame la Corte rileva dunque che la Ctr, con un superficiale apprezzamento delle circostanze di fatto e con una insufficiente motivazione, trascurando i numerosi elementi oggettivi che l'amministrazione aveva offerto al fine di dimostrare che le dette cessioni integravano operazioni soggettivamente inesistenti nelle quali la società svolgeva il ruolo di "cartiera", ossia di ente fittiziamente interposto tra l'effettiva cedente e la reale cessionaria, aveva (erroneamente) reputato illegittimi gli avvisi a carico della stessa contribuente, basando la propria decisione sull'unico, debole, elemento dell'archiviazione penale a carico dell'amministratore della società.
In conclusione, a prescindere dallo specifico caso processuale, la Corte evidenzia che, sotto il profilo probatorio, la prova dell'inesistenza delle operazioni può ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (cfr Cassazione n. 9108/2012).
Le due questioni della detraibilità dell'Iva e della deducibilità dei costi, come visto, vanno comunque esaminate distintamente, essendo diversa la disciplina di riferimento nell'uno o nell'altro caso.
Per quanto riguarda la detraibilità dell'Iva, è, in linea di principio, esclusa quando l'imposta sia stata corrisposta a un soggetto che, non avendo effettuato l'operazione, non è né legittimato ad addebitarla a titolo di rivalsa, né tenuto a versarla all'erario (cfr Cassazione nn. 20060/2015 e 27555/2018).
Per quanto riguardava, invece, la deducibilità dei costi, come conferma anche la pronuncia in commento, resta sempre ferma la necessità della verifica della concreta deducibilità degli stessi in relazione ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
Il principio di inerenza mantiene quindi comunque la sua rilevanza anche (anzi, potremmo dire, soprattutto) in presenza di costi da reato.
© Riproduzione Riservata